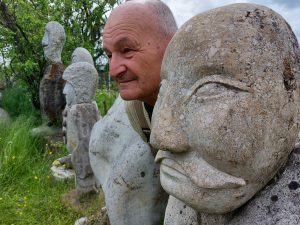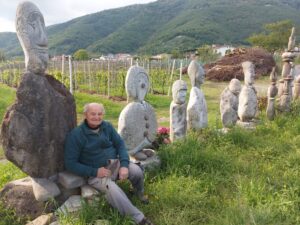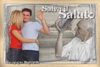IL GIOVANE RAGIONIERE DIVENTATO “SCARPARO”
È tra i più giovani artigiani di bottega d Italia, che doveva fare il ragioniere, ma preferisce aggiustare scarpe.
“Scarparo”, voce dialettale veneta per indicare il mestiere del calzolaio o ciabattino. Questo dicono i vocabolari, per identificare un mestiere tra i più umili e utili del passato.
Non esiste quasi più nessuno capace di “farci le scarpe”. Pochi coloro che sanno ancora risuolare, mettere un tacco o cucire una tomaia. Così ci tocca buttare via le scarpe perché nessuno le sa più ripararle, alla faccia del riciclo cosciente che eviterebbe l’eccesso di consumi e sprechi.
Così con la scomparsa di un mestiere, s’interrompe un ciclo virtuoso. Ma non è detta l’ultima parola, almeno fino a quando ci sarà anche un solo ragazzo, disposto a diventare calzolaio, pur avendo studiato altro. Come Alessandro Franzina, 19 anni di Montegalda, un piccolo paese del vicentino, che pur essendosi diplomato in ragioneria, ha preferito seguire l’istinto famigliare, che dopo il bisnonno, nonno e padre, lo sta facendo diventare l’erede di chi ti aggiusta le scarpe.
Oggi è tra i più giovani calzolai del Veneto e tra i pochi in Italia, che lo vede ancora un “apprendista” nella bottega di famiglia a pochi metri dalla famosa Basilica Palladiana nel cuore di Vicenza. Qui, da più di trent’anni è ubicato il negozio del papà Michele, che si fregia di aver fatto con suo padre recentemente scomparso, “le scarpe a mezza Vicenza”.

Non è difficile crederci, considerando che il nonno Franco, poi il papà Michele e oggi la zia Monica, c’è spazio per Alessandro, a rilanciare la tradizione di famiglia.
“Tutto nasce con il bisnonno Rino – ci racconta il giovane “scarparo”-, che aprì la prima bottega in provincia, dove trovò impiego poi mio nonno Franco e successivamente papà Michele, che spostandosi nel cuore cittadino, dagli anni ’60 hanno ancora la loro bottega. Dentro poco è cambiato dai tempi antichi. I materiali sono quasi gli stessi e gli odori seguono poco la moda delle scarpe che serpeggia nella storia.

Una “botteghetta” in veneto, dove si lavora alacremente e il lavoro non manca. Ogni giorno Alessandro parte con la sua famiglia dalla piccola Montegalda, dov’è nato e vive, per indossare in città, la “traversa de cuoio”, il grembiule di cuoio che è la sua “divisa” ufficiale di prossimo calzolaio. Dentro la bottega tutto è in movimento: ci sono tacchi, suole, borse, cinture, tomaie, forme da risistemare, dove il principio di fondo resta quello di recuperare quelle scarpe che invece andrebbero buttate. Motore dell’usa e getta: «Una tendenza moderna di questi anni –tiene a precisare papà Michele-, considerando come fino a pochi anni fa, le scarpe passavano di piede in piede, sempre con i dovuti aggiustamenti». Oggi tutto appare diverso, anche se vedendo la frenesia con cui si opera nella bottega, sono ancora molti coloro che scelgono la strada del “rammendo”, preferendo farsi aggiustare le scarpe, che in città significa modelli che valgono anche migliaia di euro.

Alessandro sa che deve ancora imparare molto, e sorride alla domanda su cosa prova nel sapere di essere il più giovane calzolaio del Veneto? Per ora sa benissimo di “essere un apprendista che deve fare ancora tanta esperienza”. Eppure, diventare “scarpari” oggi non sembra affatto scontato e non rappresenta di certo un mestiere che i giovani vorrebbero fare. “Più sicuro fare il ragioniere o aggiustare scarpe?” gli chiedo. Per Alessandro però, è questione di cuore: «E’ ciò che ha sempre fatto mio padre, mio nonno e ancor prima bisnonno. Perché non debbo farlo io!? Non è stato difficile ultimata la ragioneria, scegliere ciò che dovevo fare, che non è affatto quello per cui ho studiato. Il mestiere lo conoscevo già visto che durante le vacanze estive venivo ad aiutare mio padre in bottega, con l’occhio che carpiva quei movimenti, la tecnica e i segreti (pochi per la verità!), necessari per aggiustare un paio di scarpe». E’ così che ti sei “innamorato” del mestiere? «Se guardo i miei coetanei e compagni –aggiunge il giovane Alessandro-, mi sento un fuori dal coro o aspettative comuni. Ma se guardo alla mia famiglia, mi sento dentro la tradizione che porta il peso e l’orgoglio di tre generazioni. Confesso poi che questo mi stimola molto più che stare davanti a un computer per una vita dentro una banca!».

Con una variabile che è segno dei tempi che cambiano anche per i calzolai: a fianco di due uomini, a fare squadra da qualche anno, troviamo la zia Monica che dopo la morte del capostipite Franco, scelse di lasciare il mondo orafo, per aiutare il fratello Michele in bottega. «Di lavoro ce né in quantità –spiega la zia Monica, indicando gli scaffali-, al punto che non ci basta lavorare dal lunedì al venerdì, per dieci o dodici ore di fila. Il nostro è un mestiere in continua evoluzione per via del mutare dei tempi, mode e materiali sempre più moderni. Combattiamo però contro la tecnologia che vorrebbe dettare i tempi anche ai calzolai. Oggi i nostri clienti travolti dai social, si scordano che questo rimane un mestiere artigianale che richiede dedizione, manualità e tempi antichi». Dedizione che il padre sta tramandando al giovane figlio quasi per osmosi: «Ma in assoluta autonomia!» come ribadisce il maestro di bottega.
Zia Monica che lo ascolta da un angolo della bottega, aggiunge: «Il ragazzo ci sa fare, e qui di lavoro ce né tanto, se si ha voglia di lavorare!». Dalla bottega escono fino a 25-30 scarpe il giorno, che una volta riparate, possono tornare a camminare per strada. Sei mani che in bottega si muovono autonomamente, con Alessandro che per ora sistema cinghiette, fodere e tomaie, mentre il padre fa la parte grossa delle suole, tacchi e rialzi ortopedici.

Monica è tutta dedita al settore femminile di borse e scarpe di lusso. Scarpe dalle firme più blasonate e costosissime, affiancate a quelle più semplici e comuni: «In questo non facciamo differenza. Usiamo la medesima attenzione indistintamente per ogni genere di scarpa. L’importante, resta sempre lavorare bene!» conclude Alessandro, ricordandoci come in ogni scarpa, vi sia un pezzo di storia e vita di chi le indossa, che lui è chiamato –come è stato da sempre- ad aggiustare.
Copyright@ntonioGregolin24. Tutti i diritti riservati anche parziali